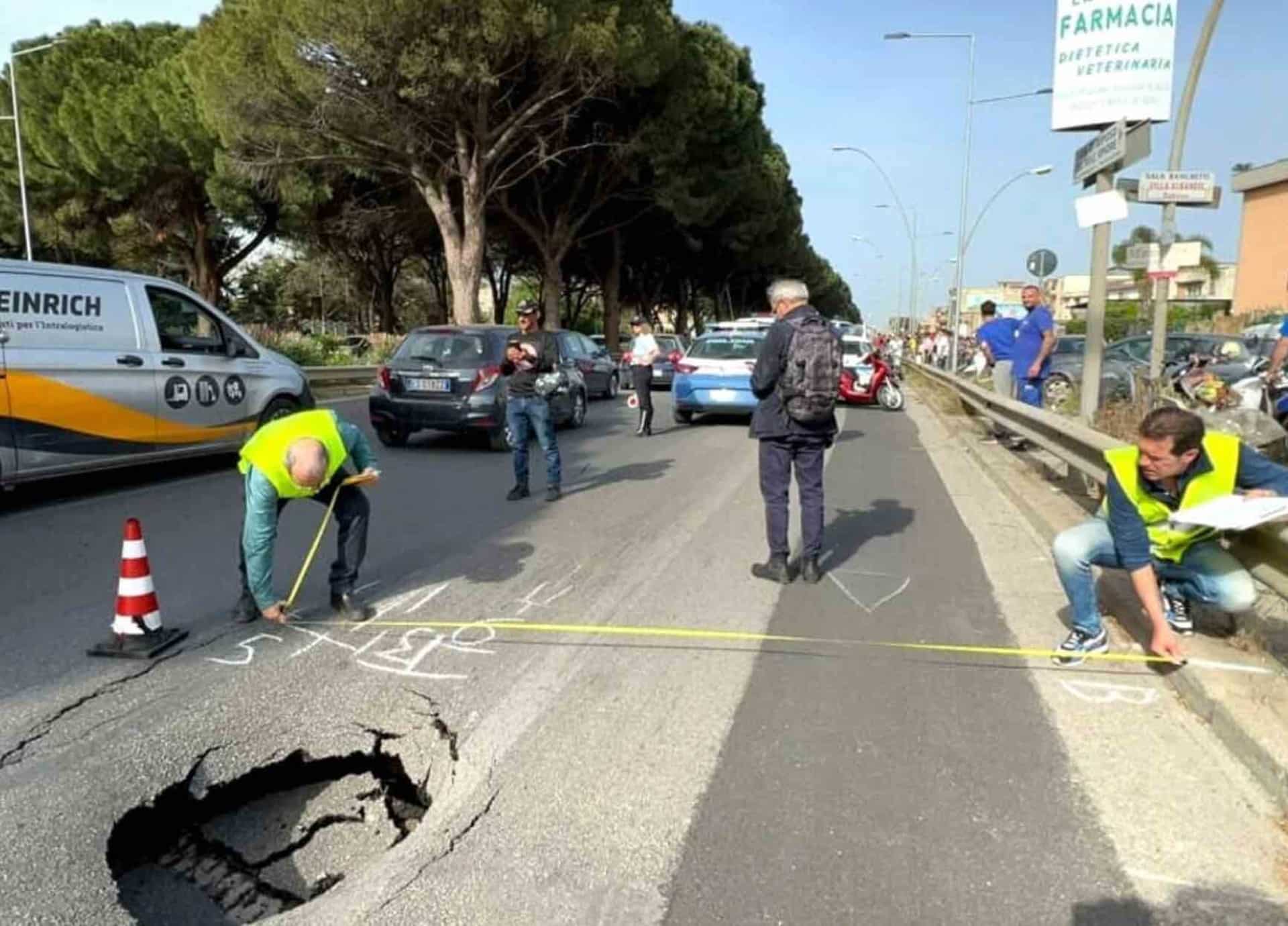Il 5 novembre 2024 si sono svolte le elezioni negli Stati Uniti, in una corsa presidenziale che resterà impressa nella memoria per lungo tempo, anche per via della spettacolarizzazione televisiva, costata quasi due miliardi di dollari.
Uno spettacolo, ormai diventato un reality show, che va avanti dal 1960, quando lo scontro decisivo in tv tra Kennedy e Nixon cambiò le regole del gioco, favorendo il candidato più telegenico. Oggi il “politainment” si riproduce nella sua chiave più moderna, arricchito dall’utilizzo dei social media e di mezzi di comunicazione più avanzati.
Sfida elettorale a suon di miliardi
Per mesi abbiamo assistito ad apparizioni nei talk show più famosi e dibatti su ABC; nonché a personaggi famosi che si sono schierati con l’uno o con l’altro candidato, diffondendo scandali, drammi e diverse imposture. Da Taylor Swift che ha dedicato un post su Instagram a sostegno di Harris, a Eminem che ha presentato l’ex presidente Obama durante un comizio in Michigan della candidata democratica. Ma c’è anche chi ha scelto di contribuire con un sostegno più concreto, come Elon Musk, che alla fine di ottobre aveva già donato 44 milioni di dollari alla Super PAC a sostegno del candidato repubblicano, oltre ad aver avviato una lotteria a sorteggio dal valore di 1 milione di dollari al giorno rivolta agli elettori firmatari di una petizione pro Trump. Sul fronte opposto, Bill Gates, fondatore di Microsoft, ha rotto i protocolli di riservatezza con una donazione a sostegno della campagna elettorale democratica equivalente a 50 milioni di dollari.
Il risultato è ormai noto: Donald Trump ha vinto con un margine di distacco che in pochi si aspettavano alla vigilia. A differenza del 2016, il candidato repubblicano ha vinto anche sul piano del voto popolare, oltreché su quello dei Grandi Elettori, e ha guadagnato il Senato, vera istituzione di potere nel complesso politico-istituzionale statunitense.
Nella corsa alla Casa Bianca ha dunque prevalso l’icona della ricchezza, del populismo, dell’esagerazione e dell’eccentricità, abile nell’uso di parole, formule evocative, di nomignoli e soprannomi che rimangono impressi nella mente di tutti, tra cui i famosissimi “Crooked Hillary” riferito alla democratica Hillary Clinton, e l’epico “Sleepy Joe”, contro l’ex Presidente Joe Biden.
Sul fronte opposto, i democratici avevano scelto di puntare su Kamala Harris: una donna intraprendente, figlia di due immigrati, che ha tentato di far sentire rappresentata la middle class statunitense. Ma non le è bastato inserirsi nel solco tracciato da Obama, che a suo tempo aveva già compreso l’importanza di saper conquistare gli elettori di origini afroamericane con una narrazione che lo presentava con la maschera dell’homo novus, estraneo all’élite che aveva causato la crisi finanziaria degli anni precedenti.
Non le è bastato neppure presentarsi come la candidata più distante al mondo da Trump. In un momento in cui l’ordine globale si mostra sempre più fragile, la globalizzazione intesa come ineluttabile espressione dell’egemonia statunitense costituitasi alla fine del secolo scorso inizia a palesare i primi segni di decadimento, basta poco per far emergere le differenze di facciata, scovando quel punto di congiuntura che, al netto di qualsiasi risultato, rende queste due figure apparentemente opposte, ma perfettamente interscambiabili. Trump e Harris sono strenui difensori e sbandieratori di una democrazia liberale intrisa di contraddizioni e ipocrisia, che si macchia delle violazioni più gravi ed eclatanti di ogni qualsivoglia principio democratico e di rispetto dei diritti umani.
Dietro la propaganda una crisi profonda e una nazione spaccata
Sicuramente è ancora presto per scandagliare le ragioni che hanno portato alla rielezione del Tycoon, ma è evidente il peso della scelta tardiva della sfidante Harris da parte dell’establishment democratico, che ha espresso un candidato con nomina dall’alto, senza passare per la kermesse delle primarie. Sicuramente hanno pesato parecchio le questioni “interne” (economia, migrazioni dal confine sud) in una generale percezione di peggioramento dell’American Way of Life per molti strati sociali in basso nella gerarchia del paese.
Negli ultimi vent’anni, infatti, il potere d’acquisto della popolazione americana è colato a picco, spingendo la popolazione a indebitarsi a dismisura per poter acquistare anche beni di prima necessità come un’auto o un’assicurazione sanitaria, facendo schizzare il debito privato oltre i 17.000 miliardi di dollari, secondo i dati di Trading Economics. Il costo della vita sempre crescente, a fronte di salari talmente bassi da costringere la popolazione ad essere prigioniera degli istituti finanziari, ha bloccato la mobilità sociale, mandando al macero uno degli elementi costitutivi dell’immaginario collettivo circa la presunta grandezza della nazione a stelle e strisce: «l’American dream».
Di fronte a un simile quadro, Trump con il suo entourage, e l’uscente amministrazione Biden con la nuova candidata Harris, hanno tentano di polarizzare il voto con retoriche opposte per curare lo stesso male. Come era prevedibile, ha prevalso la più decisa propaganda anti élite e antisistema di Trump, presentata in salsa sovranista e razzista, al gusto di American first, nel tentativo riuscito di insinuarsi nelle viscere dei lavoratori bianchi, impoveriti dal tracollo dell’industria americana a seguito delle grandi delocalizzazioni e dalle sempre crescenti predazioni da parte del mondo della finanza. Trump si è auto proclamato come l’ultimo baluardo a tutela del ceto medio contro i nemici interni del paese (lo Stato profondo, la grande finanza) ed esterni (gli immigrati che minacciano lo stile di vita e i valori americani). Tra i responsabili delle recenti sfortune degli Usa figurerebbero anche gli “alleati” occidentali, colpevoli di vivere sulle spalle degli americani. Non è un caso che in questa campagna elettorale Trump abbia minacciato a più riprese di imporre dazi particolarmente duri nei confronti dell’industria europea, in particolare sul settore automobilistico tedesco, o di far venir meno la difesa a tutti gli Stati della Nato che non spendono almeno il 2% del PIL per le spese militari.
Più incerti, quasi su tutta la linea, i democratici, che hanno provato a rispondere con progetti di investimento pubblico per rilanciare l’occupazione e innalzare i salari, solo in parte realizzati dal Build Back Better varato nel 2021. Una candidata di establishment come Kamala Harris, che sostanzialmente sull’economia non è stata in grado di proporre nessuna visione, se non una rivendicazione dei risultati dell’amministrazione Biden, che ha di fatto consegnato il voto di una parte consistente dei settori popolari nelle mani dei repubblicani.
Può risultare interessante gettare uno sguardo alla geografia dei risultati elettorali: la spartizione dei consensi tra Trump e la Harris si è giocata su una linea di faglia che divide la nazione in due tra Sud e aree interne (elettori repubblicani) e Nord e coste (in cui si vota per il Partito Democratico), che ricorda pericolosamente i due schieramenti che si fronteggiarono durante la guerra civile di metà Ottocento. L’esito del conflitto, che portò alla morte di più di 600.000 persone, consegnò le chiavi del paese agli industriali delle coste e del Nord, ridefinendo in maniera profonda e ad oggi immutata i rapporti di forza interni agli Stati Uniti. Questa ferita non si è mai rimarginata del tutto e, in un momento di forte incertezza tanto sul fronte interno quanto su quello esterno, torna a sanguinare copiosamente. Non è un caso che durante l’assalto a Capitol Hill i manifestanti portassero con sé le bandiere Confederate.
Un dato certo e già analizzabile riguarda la crescente sfiducia della popolazione verso la grandezza della Nazione e dei suoi rappresentanti: ne è un sintomo il fatto che, nel 2023, secondo i dati riportati dalla rivista Aliseo, sono state reclutate ben 41.000 unità in meno rispetto al target previsto tra Esercito, Aeronautica e Marina. Il risultato? Le dimensioni dell’arma terrestre americana sono calate a 452.000 unità: il dato più basso dal 1940 ad oggi. «È genericamente crollata la fiducia nelle istituzioni, l’orgoglio per il paese e il livello di pariottismo» – ha commentato la segretaria dell’Esercito Christine Wormuth in un’intervista al Washington Post.
Pesa di certo, la condizione di belligeranza permanente degli Usa che va avanti dal secondo conflitto mondiale e che li vede coinvolti nei maggiori fronti di guerra in tutto il pianeta, con tutti i costi umani, psicologici ed economici che questo comporta. A ciò si aggiungono le umilianti sconfitte in Iraq e Afghanistan, che hanno contribuito e non poco a minare la fiducia interna della popolazione nei confronti dell’hard power americano. Anche su questo fronte – per quanto vada la pena specificare che per il grosso degli elettori americani, le vicende belliche che si consumano ai confini dell’Europa sono accadimenti lontani che ronzano come fastidi più che impensierire realmente – è parso più deciso Trump, che non ha mancato di sottolineare, assieme alle evocazioni di una nuova epoca dell’oro e del pugno duro sulle migrazioni, il fatto che non inizierà nuove guerre e concluderà quelle in corso.
Quali scenari possibili?
Cosa sarà fatto dal secondo corso del trumpismo, se vi sarà un reale disimpegno in Ucraina, se Trump darà effettivamente carta bianca ad Israele, e quali saranno i risultati delle politiche protezioniste che ha rivendicato sull’Europa, è ancora tutto da vedere. Bisognerà pure capire come i suoi alleati dell’internazionale sovranista in UE ed in Italia si riposizioneranno di fronte a questa vittoria.
Quel che è certo è che alle nostre latitudini, soprattutto a sinistra, la vittoria di Trump getta un’aria ancora più opprimente e depressiva. Ma è evidente che se non si affrontano seriamente i nodi che sono all’origine dell’ascesa internazionale dei sovranisti in tutto il mondo, non si possono trovare nuovi riferimenti per praticare una trasformazione radicale dello stato di cose presenti.