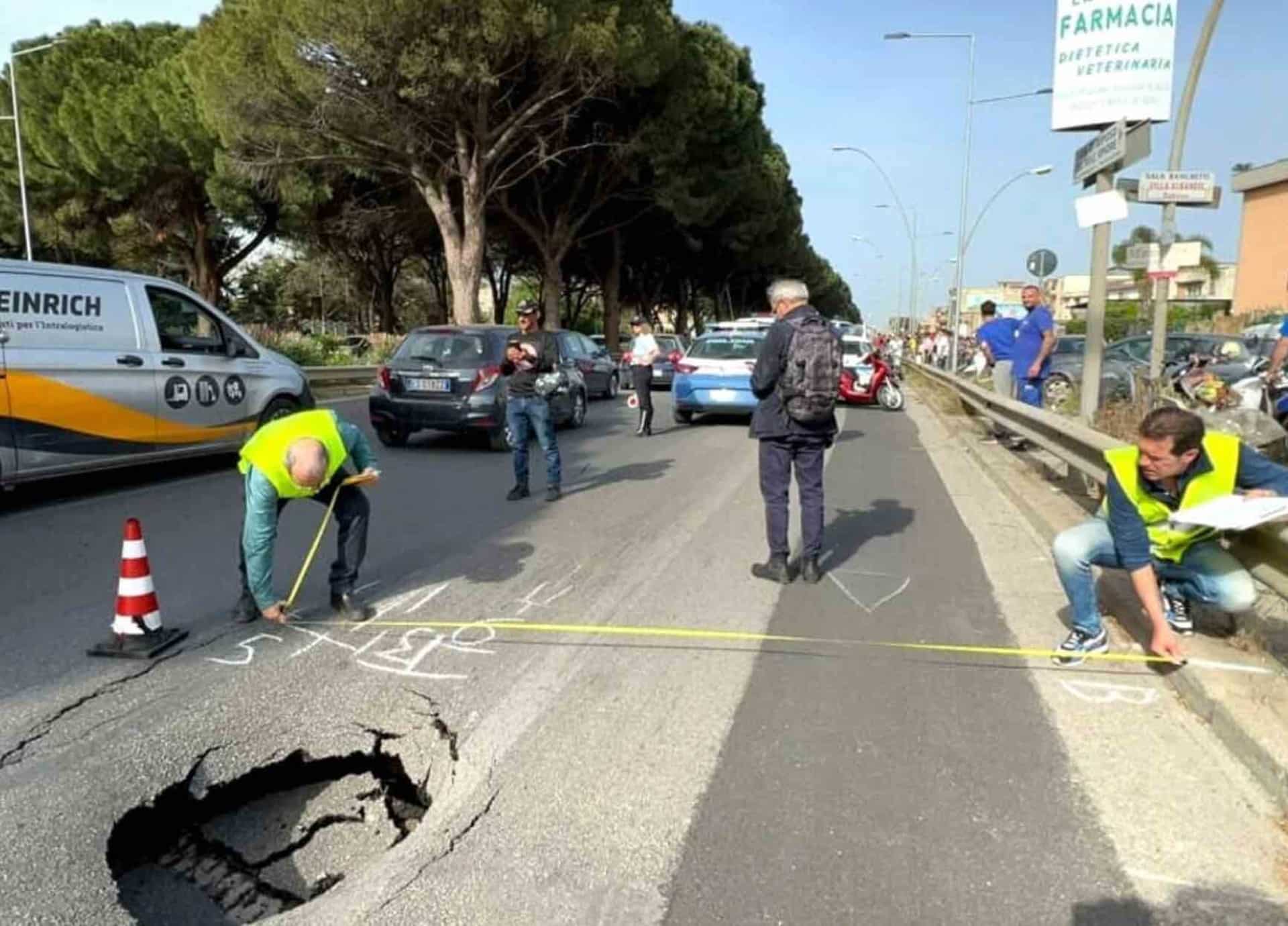di Fabio Petrucci
Considerata dall’autorevole storico Francesco Renda la “prima grande tragedia dell’Italia liberata” dal nazifascismo, la “Strage del Pane” consumatasi a Palermo il 19 ottobre 1944 rappresenta ancora oggi una ferita aperta per la città in cui ebbe luogo. Una ferita aperta sia perché per troppo tempo nascosta nel cassetto della memoria più indicibile della storia italiana sia perché le sue cause, malgrado il mutato contesto storico-sociale, sono ancora attuali e vive.
Accaduta la mattina di un giorno d’ottobre del 1944, nei pressi di Palazzo Comitini, nella centralissima via Maqueda, allora sede della Prefettura e dell’Alto Commissariato per la Sicilia, la tragedia condusse nel giro di pochi minuti alla morte di 24 manifestanti ed al ferimento di altre 158 persone. Un bilancio gravissimo.
Quella mattina un folto gruppo di manifestanti, partiti in corteo da via Cavour, aveva deciso di recarsi alle porte di Palazzo Comitini per protestare contro il carovita dilagante – dovuto sia alla guerra in corso che alle condizioni socio-economiche già pessime in cui versava la Sicilia. Un corteo percorso in nome del pane e della fame, nel quale non mancarono anche gli slogan contro il vergognoso fenomeno della borsa nera. Un corteo a cui presero parte non solo proletari, ma anche molti impiegati comunali in attesa di adeguamento salariale, nonché simpatizzanti del Movimento per l’Indipendenza della Sicilia, all’epoca il principale raggruppamento politico attivo nell’isola.
Il clima di tensione era alto, poiché drammatiche erano le condizioni di vita causate dalla guerra e prossima all’esplosione la lotta politica relativa allo status geopolitico della Sicilia, all’epoca agitata da una fortissima ondata indipendentista, non ancora efficacemente arginata dal governo italiano. A far precipitare la situazione, quel maledetto 19 ottobre, sarà soprattutto l’assenza del Prefetto Paolo D’Antoni e dell’Alto Commissario Salvatore Aldisio, entrambi a Roma per incontri istituzionali.
In questo frangente di grave tensione, il Viceprefetto di Palermo Giuseppe Pampillonia, in preda al panico ed all’irrazionalità, decise di chiedere il soccorso del Comando militare della Sicilia, reclamando l’invio di un numero di uomini sufficiente e ben armato per presidiare Palazzo Comitini. Tale scelta non farà altro che rivelarsi criminale, mostrando alla cittadinanza di Palermo richiedente pane e migliori condizioni di vita il volto peggiore della repressione esercitata dal Regno d’Italia.
Fu così che, provenienti dalla Caserma Scianna di Corso Calatafimi, dopo una sosta in questura, i circa 50 soldati della divisione Sabaudia (molti dei quali sardi, capitanati da un giovane di Canicattì) si ritrovarono davanti alla folla palermitana. D’improvviso, senza che vi fossero state provocazioni o motivi sufficienti a giustificare una reazione armata, i soldati – equipaggiati di moschetti e bombe a mano – iniziarono il massacro, colpendo a casaccio i dimostranti. 24 di essi perderanno la vita.
Il giorno seguente alla strage il Giornale di Sicilia scriverà: «Poco prima di mezzogiorno molte migliaia di scioperanti sono affluiti in via Maqueda […]. La folla con alte grida ha chiesto insistentemente il pronto intervento delle Autorità per reprimere gli abusi del mercato annonario, che provoca insostenibili disagi fra le classi lavoratrici a reddito fisso. Poco dopo le forze di polizia […] sono state rafforzate da reparti di soldati inviati d’urgenza a bordo di autocarri. […] Ad un tratto sono rintonate delle detonazioni».
All’ingiustizia di una strage dalle caratteristiche criminali, della quale si tenterà di incolpare gli indipendentisti, si aggiungerà l’ingiustizia del verdetto giudiziario, che nel 1947 – al termine di un processo-farsa che infittisce il mistero sulla vicenda – condurrà all’assoluzione di tutti i militari coinvolti, in quanto i delitti risultavano già amnistiati dal 1946. All’assoluzione per gli esecutori materiali si unì la mancanza di un’indagine seria sui mandanti – militari e politici – dell’eccidio, sul quale da quel momento calerà un silenzio pressocché tombale per decenni. Un silenzio che stride ancor più se paragonato all’enorme eco che avrà invece una strage avvenuta pochi anni dopo, nel 1947, quella di Portella della Ginestra, forse il primo vero esempio di strategia della tensione nell’Italia repubblicana.
Occorrerà attendere il 1994 per un primo tributo istituzionale ai caduti, ad opera della Provincia Regionale di Palermo, con l’affissione di una lapide commemorativa nell’atrio di Palazzo Comitini. Solo nel 2015 arriverà il tributo del Comune di Palermo, con una lapide posta all’esterno del Palazzo, lato vicolo di Sant’Orsola (uno dei punti in cui perirono più vittime). In entrambe le lapidi campeggiano i nomi dei 24 morti (tra cui due bambini di 9 e 12 anni).
Malgrado siano passati quasi ottant’anni da quel terribile eccidio, e nonostante le notevoli differenze di contesto rispetto ai giorni nostri, la “Strage del Pane” ci interroga sulle analogie con il presente a cui la storia mette davanti chi la osserva. Anche oggi, infatti, una nuova e grande ondata di “carovita” è ormai tragicamente alle porte, e con essa la prospettiva di nuove lotte di piazza, forse unico strumento rimasto davanti ad una crisi di rappresentanza senza eguali nella storia repubblicana; anche oggi – come nel 1944 – le condizioni sociali, economiche e politiche della Sicilia appaiono avviate verso l’abbandono, la povertà, l’irrilevanza e l’umiliazione da parte di istituzioni incapaci di fronteggiare la crisi, se non addirittura ostili alla cittadinanza. Non siamo ancora alla strage (per fortuna), ma già alla miseria crescente.
Anche per questo ricordare la “Strage del Pane” è oggi più che mai atto politico e non solo doveroso ricordo di un evento luttuoso del nostro passato.