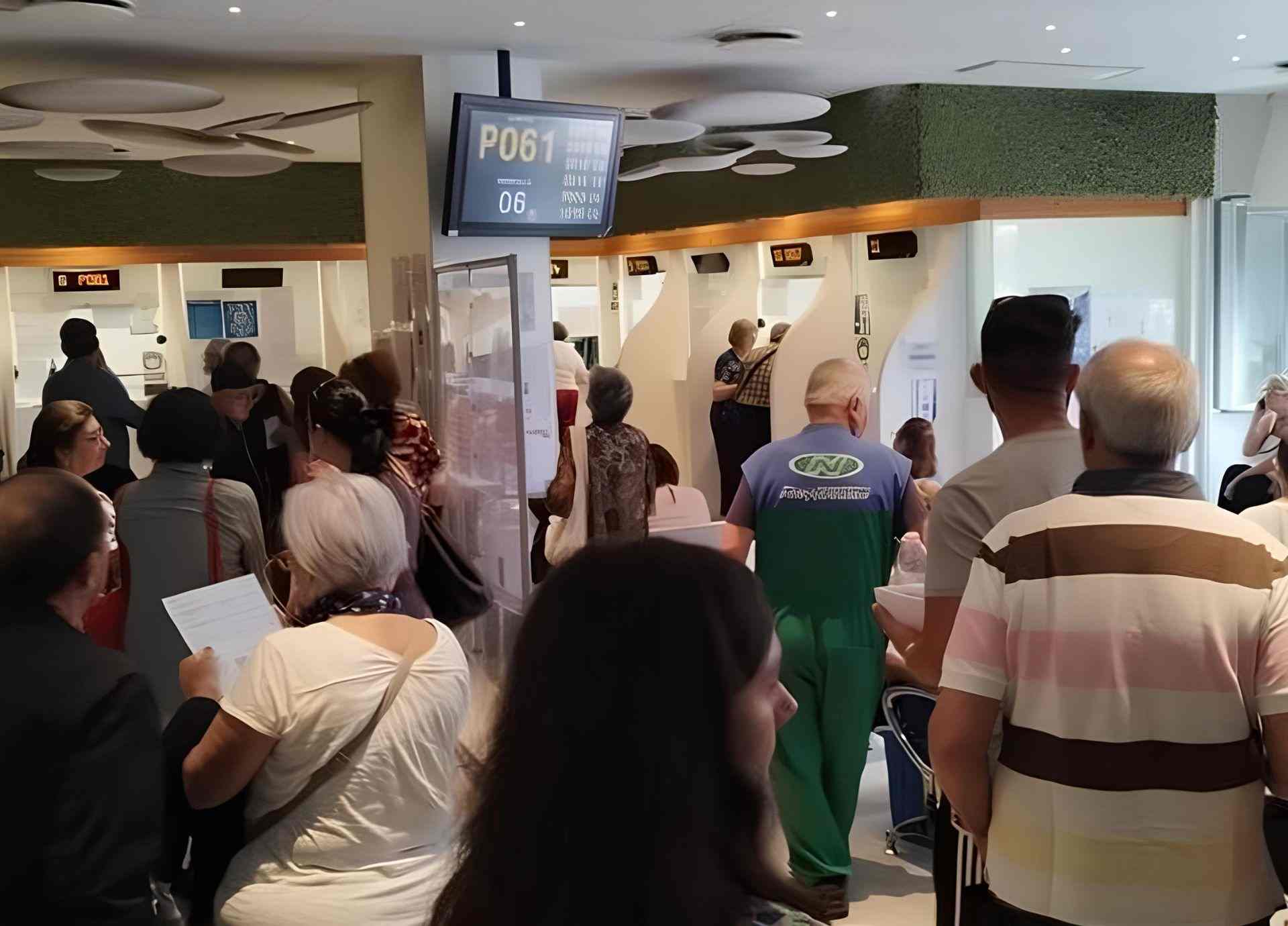La storia dei rapporti economici tra Sicilia e Stato italiano è cosa nota: non ha mai brillato per trasparenza ed equità. Nel corso dei decenni sono stati innumerevoli gli accordi istituzionali quantomeno ambigui, in cui la fregatura per i siciliani era sempre dietro l’angolo. Purtroppo è già tempo di scrivere un altro capitolo, legato all’improvviso dietrofront della Regione Siciliana nella concessione di una parte (seppur minima) delle royalties derivanti dall’estrazione di idrocarburi nei giacimenti Argo e Cassiopea ai comuni di Gela, Licata e Butera.
Oltre il danno, la beffa
La decisione è divenuta ufficiale mediante un decreto del 18 marzo di quest’anno, ma è stata resa nota soltanto in seguito alle critiche giunte dall’ex sindaco di Licata, Angelo Cambiano: ‹‹la Regione Siciliana, invece di difendere gli interessi dei propri cittadini, ha scelto di accettare passivamente la normativa vigente sulle estrazioni, rinunciando a garantire parte delle royalties alle città coinvolte››.
Tutto ciò è stato possibile grazie alla cura maniacale della burocrazia italiana quando si tratta di scovare cavilli utili a sottrarre risorse alla Sicilia. La nostra isola, infatti, non ha alcun diritto a ricevere parte delle royalties, poiché, secondo il governo nazionale, l’estrazione di gas avviene a oltre 12 miglia dalla costa siciliana. Poco importa se i pescatori siano stati comunque costretti a interrompere le proprie attività per mesi, o se la popolazione pagherà, ancora una volta, le conseguenze dell’impatto ambientale. Oltre il danno, pure la beffa.
La vicenda ha scoperchiato il vaso di Pandora della gestione delle royalties in Sicilia: una strana faccenda, di difficile comprensione, in cui l’unica certezza è che, sebbene da decenni l’isola sia il principale polo di estrazione e di raffinazione dello Stato italiano, alla popolazione restano solo le briciole.
Il seguente scritto, barcamenandosi tra leggi studiate ad hoc per negare qualsiasi rivendicazione dei siciliani e amministrazioni regionali compiacenti quando non del tutto sottomesse alle richieste del governo di Roma e delle imprese, si propone di far emergere come lo Stato italiano e le aziende private abbiano generato profitti miliardari sulla pelle dei siciliani, sottraendogli risorse che gli spetterebbero di diritto.
Argo-Cassiopea: quando il cavillo è dietro l’angolo
La telenovela delle royalties prima concesse, poi ripartite e infine ritirate ai comuni di Gela, Butera e Licata, lungi dall’essere conclusa, si compone di tre capitoli, scanditi da altrettante norme regionali.
L’articolo 21 della legge regionale del 16 gennaio 2024 recita ‹‹al fine di indennizzare i Comuni costieri di Gela, Licata e Butera a titolo compensativo per l’attività estrattiva dei
giacimenti situati nel sottofondo del mare territoriale antistante, per le produzioni attivate dall’anno 2024, la regione riconosce ai medesimi comuni una quota del 30 per cento dell’aliquota prevista dal comma 1 dell’art. 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n.
625, da destinare, in misura non inferiore al 50 per cento, a spese di investimento››.
Un decreto regionale dell’11 settembre dello stesso anno ha stabilito le quote di ripartizione tra le tre città: al comune di Licata, Butera e Gela sarebbero dovuti toccare rispettivamente il 46,91 %, il 5,56 % e il 47,53 % ‹‹dell’aliquota prevista dal comma 1 dell’articolo 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625››, su cui si tornerà più approfonditamente in avanti, per via dell’importanza della norma del 96 in tutta la faccenda.
Sembrava una storia a lieto fine, ma il 18 marzo del 2025 un terzo decreto legislativo della Regione ha abrogato la norma di settembre dello scorso anno, sancendo che, se nei prossimi tre anni l’estrazione di gas continuerà a interessare aree ubicate oltre le 12 miglia dalla costa, alle tre città non spetterà un centesimo.
Cosa dice lo Statuto? Quando la legge diventa carta straccia
Al di là del caso specifico del contenzioso sui giacimenti Argo-Cassiopea, l’iniqua spartizione delle royalties tra soggetti privati, Stato italiano e Regione Siciliana si verifica sistematicamente nell’estrazione di idrocarburi, in contrasto con quanto stabilito de iure dallo Statuto della Regione Siciliana. Il titolo V del testo, relativo a “Patrimonio e Finanza”, pur non facendo esplicito riferimento alle royalties dall’estrazione degli idrocarburi, afferma chiaramente come le risorse presenti sul suolo siciliano siano di proprietà della Regione.
Secondo l’articolo 32 ‹‹I beni di demanio dello Stato, comprese le acque pubbliche esistenti nella Regione, sono assegnati alla Regione, eccetto quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale››. Invece, l’articolo 37 afferma: ‹‹Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell’accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi. L’imposta, relativa a detta quota, compete alla Regione ed è riscossa dagli organi di riscossione della medesima››.
In buona sostanza, se non per la necessità di tutelare “l’interesse nazionale” – sebbene questa stessa definizione sia giuridicamente molto ambigua – le risorse energetiche presenti nel nostro sottosuolo e, pertanto, i profitti derivanti dalla loro estrazione, sarebbero sotto la tutela dell’amministrazione regionale. Non crediamo sconvolgerà nessuno sapere che ciò, di fatto, non è mai accaduto. Mancando i decreti attuativi, lo Stato italiano non si è preso la briga di applicare alla lettera quanto sancito dal testo del 46’ e nessun politico siciliano ha avuto il coraggio di affrontare fino in fondo lo scontro col governo di Roma per tutelare gli interessi dei siciliani.
La concessione e la spartizione delle royalties, lungi dall’essere di esclusiva competenza della Regione Siciliana, è sempre avvenuta in accordo con le condizioni poste dallo Stato centrale. Come? Scopriamolo.
Una fregatura che vale miliardi
Per comprendere nel dettaglio l’intero meccanismo è necessario tornare al Dlgs 625/1996 citato poc’anzi. Questa legge nazionale è stata emanata per disciplinare le modalità di versamento delle aliquote agli enti istituzionali da parte delle imprese concessionarie dell’estrazione di idrocarburi.
Il comma 1 dell’articolo 19, in particolare, stabilisce un’aliquota del 7% per i giacimenti su terraferma e del 4% per quelli situati in mare. In concreto, ciò significa che se un’impresa estrae risorse per un valore complessivo di 100€ al netto di ogni tassazione del prodotto finale, 93€ se li tiene l’azienda privata (96€ se l’estrazione avviene in mare) mentre quel poco che rimane finisce nelle tasche del governo centrale, che tratterrà una parte della quota per sé e ripartirà il resto tra le regioni e i comuni interessati.
Poiché la Sicilia è una regione a Statuto speciale stabilisce i criteri di ripartizione in accordo col governo centrale. Ci si potrebbe aspettare che le amministrazioni nostrane abbiano battuto i pugni sul banco per garantire quante più risorse possibili da destinare allo sviluppo socioeconomico della nostra isola, facendo gli interessi di tutti i siciliani. Ma non è andata esattamente così.
Si prenda in considerazione il periodo 2001-2009. La legge regionale 388/2000 destina il 70% delle risorse alla Regione (da dividersi con i comuni coinvolti) e il restante 30% allo Stato. A leggere i dati parrebbe una gran cosa, ma bisogna tener conto che questa spartizione avviene, come spiegato precedentemente, sulla base di quel poco che le imprese private lasciano nelle mani degli enti pubblici. In soldoni, se alle imprese concessionarie sono andati la bellezza di 2,168 miliardi euro e allo Stato italiano 45,9 milioni nel giro di nove anni, la Regione ha ricevuto 35,7 milioni, mentre 71,3 milioni sono stati divisi tra gli innumerevoli comuni interessati.
I soldi entrano dalla porta ed escono dalla finestra
Nel 2013 è arrivata una svolta storica, in apparente contraddizione con quanto è stato descritto finora. Secondo l’articolo 13 della Legge 19/2013, infatti, il valore delle royalties è aumentato al 20% senza franchigia del totale prodotto e, dulcis in fundo, è prevista una ripartizione equivalente ad 1/3 alla Regione Siciliana e a 2/3 ai Comuni nei cui territori ricade il giacimento. In parole povere, lo Stato italiano dal 2013 non riscuote più alcuna quota derivante dalle royalties, la cui percentuale si è notevolmente innalzata rispetto agli anni precedenti. L’unica eccezione è relativa al triennio 2020-2022, quando lo Stato italiano ha tenuto per sé il 100% delle royalties a causa della crisi economica innescata dalla pandemia.
Parrebbe che qualcuno dalle parti di via XX Settembre abbia preso una botta in testa, o un rimorso di coscienza, decidendo di attribuire l’intero valore delle royalties estratte in Sicilia al popolo siciliano. Purtroppo per noi, la musica è ben diversa.
Infatti, una manciata di mesi dopo la pubblicazione della Legge 19/2013, l’allora Presidente della Regione Rosario Crocetta, dopo aver millantato l’acquisizione esclusiva delle royalties come un grande risultato politico, tentò senza successo di abbassare l’aliquota dal 20% appena stabilito al 13%, mascherando la sudditanza alle aziende private dietro la volontà di attirare nell’isola investimenti a lungo termine. La manovra non riuscì per via della bocciatura da parte del commissario dello Stato.
Il vero regolamento di conti tra la Sicilia e il governo di Roma arriva l’anno dopo. La Regione Siciliana aveva aperto un contenzioso economico con lo Stato italiano nel 2013, relativo alla gestione delle risorse recuperate dall’evasione fiscale. La finanziaria nazionale di quell’anno aveva sancito come queste somme spettassero esclusivamente al governo centrale, scatenando l’opposizione delle Regioni a Statuto speciale, Sicilia inclusa. Crocetta però, probabilmente memore del “favore sulle royalties”, nel giugno dell’anno successivo sottoscrisse un accordo con l’allora ministro per l’Economia, Piercarlo Padoan, nel quale venne sancita la rinuncia da parte della Sicilia alle somme derivanti dal contenzioso con lo Stato per il triennio 2014, 2015, 2016. Ovvero oltre un miliardo e mezzo di euro.
La sentenza della Corte costituzionale giunta nel 2015, in cui si dichiarò che i proventi recuperati dall’evasione fiscale dovessero restare nelle mani della Regione Siciliana, e come pertanto l’accordo Crocetta-Padoan fosse illegittimo, non è stata mai applicata. Il governo regionale ha scambiato la concessione delle royalties, cioè decine di milioni l’anno e, soprattutto, già spettanti di diritto alla Sicilia secondo quanto stabilito dallo Statuto, con il gettito tributario derivante dal contrasto all’evasione fiscale – anch’esso in teoria di nostra proprietà – che invece vale miliardi.
La Sicilia non si svende: royalties ai siciliani!
I numeri non mentono, e descrivono con chiarezza una questione politica prima ancora che economica. I processi estrattivi di idrocarburi, sia che avvengano in terra o in mare, compromettono lo sviluppo della nostra isola e dei comuni coinvolti in favore degli interessi delle imprese private. Città dalla forte vocazione ittica, agricola o turistica, che potrebbero sfruttare il proprio potenziale per garantire lavoro e benessere per i siciliani, si ritrovano con le gambe mozzate. L’economia di questi luoghi, e i casi di Gela e Augusta sono abbastanza esplicativi, è totalmente asservita alla produzione energetica, rendendo le produzioni locali dipendenti da imprese straniere fino all’esaurimento dei pozzi e dei giacimenti. A quel punto, in molte aree della nostra isola non resta che il deserto, perché le aziende chiudono bottega e se ne vanno, costringendo gli abitanti a fare altrettanto. Terreni agricoli fertili, paesaggi straordinari che il mondo ci invidia e scorci di mare mozzafiato sono stati distrutti e resi improduttivi da distese di pannelli solari, pale eoliche, pozzi e petroliere, mentre i siciliani si sono ritrovati con un pugno di mosche in mano.
Tutto ciò per ricevere royalties dal valore misero se comparato a quanto incassato dal governo di Roma fino al 2013 – a cui sarebbe potuto benissimo non spettare un centesimo – e soprattutto da parte delle multinazionali, che fatturano miliardi grazie a risorse di proprietà della Sicilia e dei siciliani in cambio di due spicci.
Per di più, la concessione delle royalties, peraltro con un’aliquota al 20%, ben più bassa di quanto si potrebbe pretendere da aziende concessionarie con fatturati miliardari, è arrivata come un cavallo di Troia, scambiata con risorse già di nostra proprietà che ci sono state scippate.
Insomma, in barba alla retorica trita e ritrita sulla Sicilia terra non in grado di provvedere a se stessa per l’assenza di risorse da mettere a valore, la gestione delle royalties è uno dei tanti casi che dimostra come non sia l’assenza di opportunità a mettere un freno allo sviluppo della nostra isola – né la genetica incapacità dei siciliani di farsi da sé – bensì il processo di depauperamento scientificamente perseguito dallo Stato italiano ai nostri danni. È proprio qui il cuore della questione. La gestione delle concessioni per l’estrazione delle risorse energetiche avviene in contrasto agli interessi economici e produttivi dell’isola, senza che la popolazione abbia voce in capitolo.
È lo Stato italiano che si occupa di trattare – peraltro da una posizione di estrema debolezza – con le imprese private. È lo Stato italiano a decidere, volente o nolente, di vendere a prezzo di saldo le nostre risorse alle multinazionali. È ancora una volta il governo di Roma a scegliere deliberatamente di ignorare le sue stesse leggi, gestendo come proprie risorse energetiche che non gli appartengono, salvo poi concederle solo dopo essersi appropriato del gettito tributario dell’evasione fiscale, anch’esso in teoria spettante alla Sicilia e ai siciliani. L’amministrazione regionale, dal canto suo, svolge alla perfezione il ruolo che le è stato assegnato dal governo di Roma: garantire gli interessi dell’economia italiana, guarda caso sempre coincidenti con quelli del Nord, senza battere ciglio.
L’unica soluzione politica auspicabile per i siciliani è, pertanto, pretendere non solo che le royalties siano sempre versate per tutti i giacimenti e i pozzi in nostro possesso, inclusi i giacimenti Argo-Cassiopea, ma anche una diversa ripartizione delle quote spettanti ai soggetti coinvolti a vantaggio della nostra isola, partendo dal presupposto che non si tratti di proprietà dello Stato italiano, ma di nostra ricchezza che da decenni ci viene sottratta. Le nostre risorse non posso essere regalate a Roma e ad aziende straniere che nulla fanno per la Sicilia, in cambio di una mancetta e di qualche compensazione.